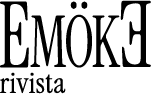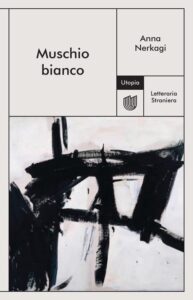
“Dov’era finita quella verità, solida come una roccia, non la verità limitata, meschina, individuale […] ma la verità che aveva tratto dalle tenebre la razza umana e l’aveva benedetta, dicendo «vivi, e bada di non fare un passo falso»?”
Muschio Bianco, edito da Utopia, è il secondo romanzo tradotto in italiano della scrittrice Anna Nerkagi. È stato pubblicato per la prima volta in Russia negli anni Novanta, a distanza di quasi vent’anni da Aniko, primo romanzo dell’autrice, di cui costituisce una sorta di seguito, riprendendone temi e personaggi. Anna Nerkagi racconta, a partire dalla propria esperienza autobiografica, la vita della comunità dei Nenec, popolo nomade e indigeno che vive di allevamento di renne nella tundra siberiana.
Lungo tutto Muschio Bianco, il lettore è accompagnato dal lamento desolato e straziante delle strolaghe, nel cui gemito angoscioso i Nenec riconoscono la disperazione di chi ha perso il proprio focolare dopo averlo costruito con fatica e amore, e di chi si trova a piangere su un passato per sempre perduto. Attorno a questi due centri ruota l’angoscia dei due anziani dell’accampamento: una è la madre di Alëška, disperata davanti al rifiuto del figlio di accogliere la propria moglie, unica possibilità di continuare a far fluire la vita tra le generazioni, l’altro è il vecchio Petko, vedovo e abbandonato dalla figlia che avrebbe dovuto prendersi cura di lui durante la vecchiaia.
A queste due visioni si oppone quella del giovane Alëška, diviso tra il dovere nei confronti della propria comunità e un altrove che lo attrae, dove vivono i molti giovani Nenec che, abbandonata da bambini la comunità per studiare, non vi hanno più fatto ritorno. Tra questi vi è anche Ilne, figlia di Petko, oggetto segreto dell’amore di Alëška e innesco del conflitto generazionale. Per Alëška è infatti il simbolo della possibilità di una realizzazione individuale che non rientra nelle regole immutabili che guidano la vita dei Nenec, per Petko è invece la desolante consapevolezza dell’abbandono e dell’impossibilità di trasmettere alla generazione successiva la propria stirpe e la verità che ne ha sempre permesso la sopravvivenza in un mondo ostile.
Il risultato è un pervasivo senso di smarrimento davanti ad una realtà che risulta incomprensibile e difficile da accettare. Gli anziani, che guardano la vita dalla prospettiva di un mondo in cui i valori erano già prestabiliti, sono continuamente stupefatti e non possono fare a meno di constatarne lo stravolgimento, interrogandosi, senza mai trovare risposta, su cosa stia accadendo al mondo:
Dov’era finita quella verità, solida come una roccia, non la verità limitata, meschina, individuale […] ma la verità che aveva tratto dalle tenebre la razza umana e l’aveva benedetta, dicendo «vivi, e bada di non fare un passo falso»?
Alëška, dal canto suo, è in cerca della propria felicità, che non crede possa coincidere con il matrimonio impostogli dalla madre in accordo con le consuetudini dei Nenec. Questo rifiuto lo getta però in uno stato di disorientamento da cui sembra impossibile uscire:
Si era smarrito come una volpe che segue le proprie orme ed era rimasto intrappolato in un cerchio da cui non poteva saltar fuori, né fuggire. E poi dove sarebbe dovuto saltare? E perché?
Come lo smarrimento di Alëška si concretizza in una volpe, così la vita interiore dei personaggi trova espressione nel continuo e pervasivo gioco di analogie con la natura e gli animali della tundra. La vivida rappresentazione dell’ambiente siberiano passa attraverso il reciproco rispecchiamento dell’uomo nella natura e del paesaggio nell’animo umano. A partire dalla convinzione che la natura abbia le stesse possibilità di sofferenza dell’uomo, la comprensione di sé avviene osservando i boschi, la neve, i muschi, le volpi, le renne, gli uccelli e tutto ciò che abita il nostro stesso spazio.
Recensione di Letizia Grosselle
Anna Nerkagi, Muschio Bianco, traduzione dal russo di Anna Cicognini, 2024, Utopia, ISBN: 9791280084705