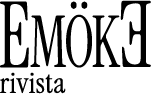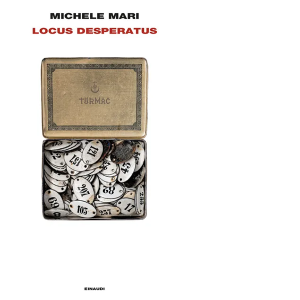
“Ridotto così, ero re: delle mie cose, delle mie collezioni, dunque di me, che in quelle collezioni avevo sistematicamente trasferito ogni mia più intima particola, fino a ricomporvi un’analitica e dissociata entelechia.”
È questa l’insospettabile colpa che perseguita il Mari protagonista dell’allucinata vicenda raccontata nel breve romanzo Locus desperatus (2024), finalista al Premio Campiello. Attorno ad essa si raccoglie la stessa costellazione di ossessioni, umane e letterarie, becere ed eroiche, pop e desuete, che ha accompagnato l’autore per tutta la sua carriera.
Saggista, traduttore, curatore, Michele Mari esordisce in narrativa nel 1989, con Di bestia in bestia, pubblicando poi con ritmo più o meno regolare diciotto titoli: da Tu, sanguinosa infanzia (1997) a Verderame (2007), da Asterusher. Autobiografia per feticci (2015) a Leggenda privata (2017). Locus desperatus, per Einaudi, è di questa lunga catena l’anello più recente, il frutto più maturo, che accoglie in sé l’intima realtà autobiografica ed una grottesca e disorientante fiction.
La vicenda inizia quando, uscendo di casa una mattina, il protagonista si accorge di una strana croce bianca disegnata sul portone. Subito la sua mente congettura: un monito biblico? Una burla? Un avvenimento sovrannaturale? Non è dato sapersi – almeno fino al palesarsi dei diabolici responsabili del segno. I toni del racconto si fanno quindi vertiginosi, stralunati, memori del Processo kafkiano o di un racconto di E.T.A. Hoffmann (non a caso nominati entrambi nel volume).
La croce, viene spiegato, serve ad avvisare l’uomo del fatto che, con le buone o con le cattive, verrà attuata una sostituzione ai suoi danni, un subentro: qualcuno andrà a vivere in casa sua, tra i suoi possedimenti più cari, e a lui non resterà che scegliere se subentrare a sua volta o restare esule, secondo un costume che si protrae, segretamente, da tempo immemore (già Ulisse? Enea?). Il motivo di ciò, viene spiegato alla vittima da un paio di presunti diavoli, sta nella sua tana-museo, nelle sue cose:
Anche se non lo sapete, voi siete uno straordinario personaggio, e per questo non siete più una persona. A furia di circondarvi di cose, amandole, collezionandole, vi ci siete a poco a poco trasferito, regalando loro quote sempre più consistenti della vostra personalità. Credevate di possedere, e sarà stato pur vero: solo, vi siete spossessato. Sicché noi – noi – […] per prendervi l’anima non dobbiamo fare altro che prendere le vostre cose, lasciandovi al destino come una foglia secca.
Improbabile e nevrastenico generale dei suoi soldati-cose (non immuni dalla tentazione di ammutinarsi), il protagonista ingaggia allora la lotta contro coloro che desiderano prendere il suo posto – di uomo, e di possessore di cose –, scoprendo attorno a sé un mondo sorretto da trame abominevoli, ambiguità, scambi di persona, duplicazioni, memorie fasulle, macumbe; e ancora latinisti che fanno i baristi, idraulici mascherati da filologi romanzi, creature fatte di morchia…
Fedele alla pratica del pastiche sin dagli esordi, anche qui Mari si dimostra padrone di una tastiera linguistica contraddistinta da grandissima varietà: nel lessico, nel tono, nel registro, nell’oscillazione diacronica. La sua voce è il risultato di mille altre che lo hanno preceduto, di una tradizione e di un canone personale (non solo letterario, ma più estesamente culturale ed umano) da cui egli decide di lasciarsi attraversare, con un citazionismo esibito al massimo grado: di «beneficio dell’influenza» parlava infatti l’autore ne I demoni e la pasta sfoglia (2004), contro l’«angoscia» di Harold Bloom.
Gli stridori connaturati a questa lingua sfarzosa, manierista e barocca (gaddiana, landolfiana?) non fanno che accentuare nel lettore il sentimento, già scaturito dall’intreccio, di un mondo deforme e indecifrabile, opaco.
Anche i temi, si è detto, restano fedeli alla lunga produzione precedente, ritornando uguali a sé stessi, eppure sempre nuovi: l’autobiografia; la memoria, e la paura di dimenticare; il collezionismo (anche sotto le spoglie di una demoniaca pulsione tassonomica e catalogica); il doppio e lo sdoppiamento (gli ultracorpi); una certa vena orrorifica; l’erudizione come elemento che propelle gli eventi, e via discorrendo.
E proprio l’erudizione e la filologia, sotto il segno della crux desperationis (forse la stessa disegnata sul suo portone), offrono al protagonista il vigore necessario a combattere per proteggere il suo minuscolo cosmo museale, il titolare locus desperatus:
Ma no! Nemmeno per sogno, qui stavo e qui mi avrebbero trovato, lacunoso, corrotto, trafitto di spiedi e pugnali, ma stabile, la storia del testo aveva deciso così, fonti alternative cui attaccarsi non c’erano, si rassegnassero, filologi disperati, loro!
Recensione di Gian Marco Evangelisti
Michele Mari, Locus desperatus, 2024, Einaudi, pp. 131, ISBN: 9788806264512