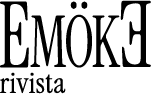“La storia è come la spugna: quando è aggrappata al fondale è tutta nera e sporca, piena di pezzi di cose attaccate, gusci di àmmari, pietrisco, catrame; per farla bella e chiara bisogna sciacquarla bene con l’acqua di mare. Solo a ripeterla tante volte, come tutti i passaggi al loro posto, la storia si libera dei dispiaceri che porta.”
L’isola e il tempo di Claudia Lanteri è una storia che parla di una verità e della memoria che essa trattiene. Una verità dolorosa, labile, che si confonde nel tempo, che non può essere sciolta se non nella reiterazione continua del ricordo. Una vicenda che prova a svelare i meccanismi della mente umana nei confronti del rimosso, rimettendo ogni filo al suo posto raccontando la storia ancora e da capo.
Precedentemente all’uscita del romanzo, nella collana Unici di Einaudi, Claudia Lanteri ha pubblicato racconti su varie riviste: «Snaporaz», «Malgrado le Mosche», «Micorrize».
La vicenda di Unici muove all’interno di un’isola minuscola, uno spazio limitato, un fazzoletto di terra. Lungo il racconto l’isola vulcanica prende forma componendosi di calette, picchi di montagna e una natura selvaggia. Nelle lunghe camminate del narratore emergono quei posti che saranno il palcoscenico dell’intera vicenda: Spaccamontagna, San Gerlando, il municipio, il bar del porto, il panificio, la caserma, lo Scalo Vecchio, la Pozzolana. L’autrice non svelerà mai il vero nome dell’isola, seppur riconoscibile attraverso i dettagliati riferimenti marittimi (Linosa, nel Canale di Sicilia). Attraverso un nome si veicola una identità e questa assenza rappresenta il narratore stesso, incapace di autodefinirsi, costretto ad entrare nel mondo adulto attraverso un’esperienza violenta del mondo che lo circonda.
Il narratore, Nonò, si presenta inizialmente come un bambino tredicenne, vivace, allegro, curioso, fiero di aver ripetuto per due volte la sesta per mancanza di altre scuole. Lo vediamo nell’incipit che percorre le ripide salite accompagnando il professore di scienza, Dalmasso, che farà da guida, intento in uno studio naturalistico dell’isola. Nell’evolversi degli eventi, nella ricerca di quella verità che sembra non tenere, ritroviamo Nonò trentenne, Nofrio, ancorato a quell’isola. Una terra animata da una comunità di pescatori e agricoltori, che rimanda agli ambienti rurali verghiani, dettata da ritmi che ancora non hanno conosciuto i violenti cambiamenti del processo industriale degli anni Sessanta.
A modificare l’equilibrio dell’isola è l’arrivo di un barchino con un naufrago e il corpo senza vita della moglie. Cominciano le ricerche e gli abitanti si animano per l’evento inatteso. I luoghi come la caserma, il porto o il pergolato di Tina scandiscono il tempo dell’indagine che sembra concludersi sommariamente: si scopre che il naufrago, Bruno Surico, è stato vittima di un incendio, di cui lui è l’unico superstite. Il caso si archivia, ma la verità non convince Nonò, che segue attentamente, nascosto e solo, il volgersi delle vicende.
Il tempo, che dà titolo al romanzo, è un eterno presente e appartenere alla memoria di Nonò. Il ricordo si confonde, si ingarbuglia su sé stesso producendo un effetto di spaesamento. La voce del protagonista è mobile: si allontana o si avvicina ad un punto focale, ad un nucleo fatto di assenza, di vuoto. Ecco che allora la chiave per leggere il romanzo non è solo nella risoluzione del plot, ma nel seguire l’andamento della memoria di fronte al rimosso. Nofrio cerca di variare il corso degli eventi, di costruire nuovi orizzonti, utopie per arrivare a sciogliere la matassa. Ma il resoconto sembra non arrivare mai al pareggio. E la voce del narratore si confonde; il lettore si domanda se può affidarsi davvero alla sua una memoria, una memoria colpita dal dolore.
Definito un “giallo della memoria”, il romanzo utilizza l’indagine come orizzonte per una storia più grande: la ricerca affannosa e straziante della verità nella solitudine: «L’invenzione dà forma al disordine, oppure impazzisce, ci si perde a inseguire i fili sparsi nella memoria: nel raccontare la trama, quello che è stato nel passato non è tanto diverso da quello che non è stato».
E conclude con un interrogativo chiave:
« – non hai paura?
– Ho fatto la mia vita.
– E ti è bastata la vita tua?
– Le persone a cui ho fatto del bene mi ricorderanno.
– Tutti allora ti ricorderanno.
– Anche senza volerlo avrò fatto del male, Nofriu mio.
– Ma si può chiamare male qualcosa di cui non abbiamo coscienza?».
Lo stile mescola elementi dialettali provenienti dalle voci dell’isola in un andamento dinamico. Nella scrittura di Claudia Lanteri, la densità letteraria si fonde con la trama, nel duplice piano narrativo e nella coralità di voci che cercano di raggiungere una verità. L’isola richiama per antonomasia l’opera di Elsa Morante, non solo per l’ambientazione insulare ma per la capacità di trasformare lo spazio fisico in metafora esistenziale. Un luogo dove la solitudine è l’unico interlocutore, sospeso nello spazio e nel tempo.
Recensione di Sofia Crincoli
Claudia Lanteri, L’isola e il tempo, 2024, Einaudi, pp. 368, ISBN: 9788806261160