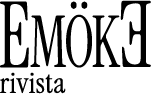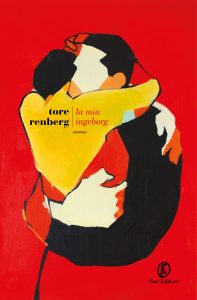
“C’era qualcosa che non andava con la bocca di Oddo. Oddo, diceva. Non era in grado di pronunciare il suo nome, Otto, come facevano gli altri, ma solo come gli sembrava di sentirlo dire con le sue orecchie. Devi cercare di dire la T, gli suggerivo. D, diceva. Riprova. T. E nessuno potrà più canzonarti. Canzonarmi?, chiedeva Oddo. Sì, devi imparare a difenderti da solo e, se vuoi imparare a farlo, devi saper pronunciare bene il tuo nome”.
Tore Renberg è nato nel 1972 a Stavanger, in Norvegia. Il suo esordio letterario si colloca nel 1995 con la raccolta di prose brevi Sovende floke (non tradotto in italiano), alla quale seguono raccolte di racconti, quindici romanzi, il libro di saggi På fest hos Literaturen (2012), e una cospicua produzione di libri per bambini. Riconosciuto dalla critica come uno degli autori norvegesi più importanti degli ultimi anni, Renberg, è l’autore di Tollak til Ingeborg, romanzo pubblicato per la prima volta nel 2020 e, ad ora, il suo più grande successo letterario, candidato al Premio Strega Internazionale del 2024.
Tollak della valle è un uomo taciturno, schivo, dal sangue amaro. Ormai vecchio e solo, la sua vita non è che il continuo riflesso di un passato perduto, nello specchio a cui tuttavia rifiuta tutti i giorni di specchiarsi. Non gli resta altro che il proprio nome, l’affermazione di sé, la dimostrazione di avere dentro qualcosa delle proprie origini. È proprio l’indifferenza verso questi ricordi ciò che rimprovera ai propri figli e al mondo che lo circonda, ed è questa distanza che lo fa sentire incompreso e abbandonato. Tollak vive nel passato che ha condiviso con l’amata moglie Ingeborg, scomparsa ormai da anni: solo il ricordo di lei l’ha tenuto in vita. Non ha più rapporti né con il figlio Jan Vidar, che accusa di essere un “senza palle”, né con i nipoti, a suo dire “mani morte, corpi morti e piedi morti”, incapaci di sopravvivere, a differenza sua, solo con il lavoro delle proprie mani. La figlia Hillevi lavora invece in università, è una femminista che riscrive “quell’epoca diversa” che Tollak idealizza, parlando con parole che non ha imparato a casa del padre. Unico suo confidente è Otto, o meglio Oddo, il figlio disabile, con cui abita l’isolata casa di famiglia.
C’è però qualcosa, nella figura del vecchio Tollak, che finisce per rivelare le sue profonde contraddizioni; è un uomo di poche parole che tuttavia non può impedirsi di raccontarci la sua storia, un uomo che solo con sua moglie, dice, è stato in grado di esprimere i propri sentimenti. Eppure, costruisce una narrazione che, per quanto frammentaria, si rivela essere un vero e proprio monologo, un racconto senza interlocutore, in sostanza, un memoriale. Nessuna altra voce affiora dalla nebbia della mente di Tollak, non i figli, non la moglie. Ingeborg resta idealizzata, lontana, esterna alla storia, poiché solo la versione di Tollak giunge al lettore. Ingeborg è l’unico personaggio che non può pronunciare direttamente il suo nome.
Un bicolore gioco di simmetrie generazionali si infrange, in primo luogo contro la simbologia animale che identifica i personaggi, e che è sottesa a tutta la narrazione; in secondo luogo, con la nascita di Oddo, unica evidente increspatura nell’autodifesa del padre. Tollak finisce per odiare la sua immagine riflessa, quegli occhi spiritati che non riconosce come suoi, ma che lo costringono, come il vecchio marinaio, a cercare una forma di assoluzione nel racconto.
Al lettore resta solo la fuliggine, la percezione di una lacuna, di un oscuro non detto, nonostante il dichiarato obiettivo del protagonista sia un resoconto efficace; il residuo di una memoria già per sua natura destinata a rivelarsi incompleta e deformata. Qualcosa manca alla fine di Tollak til Ingeborg, e sta proprio qui la forza del romanzo; forse il vuoto che sancisce i limiti della ricerca del nostro passato, o forse, più semplicemente, la voce di Ingeborg stessa.
Recensione di Leonardo Guizzetti
Tore Renberg, La mia ingeborg, tradotto dal norvegese da Margherita Podestà Heir, 2024, Fazi Editore, pp. 180, ISBN: 9791259671257