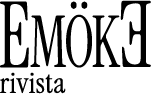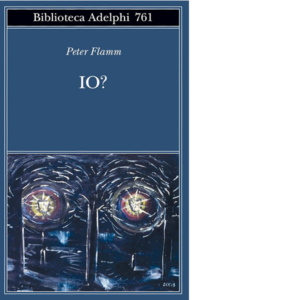
Esiste un conflitto perenne, più o meno latente, tra la teoria letteraria e la storia. Io? (Ich?) Il romanzo d’esordio dell’espressionista tedesco Peter Flamm, pubblicato per la prima volta in Italia da Adelphi in concomitanza con la nuova edizione tedesca Fisher, lo fa emergere con forza in sede di interpretazione. Uscito originariamente nel 1926, il libro porta ben visibili tutti i segni del suo periodo storico narrando la vicenda di un sopravvissuto della Prima guerra mondiale, il fornaio Wilhelm Bettuch, che recupera i documenti e l’identità di un cadavere, quello dell’agiato medico Hans Stern, per poi rientrare nella vita civile al posto di quest’ultimo, nella sua famiglia, incontrando svariate difficoltà di reinserimento in società.
Tale spunto narrativo, raccontato dal punto di vista soggettivo e inaffidabile del protagonista, genera un’atmosfera fantastica, un soprannaturale di esitazione in cui il lettore si trova perennemente in bilico tra la fede nella versione della voce narrante (che si pone come Bettuch, l’usurpatore di un’identità rubata) e il sospetto di una pazzia tout-court accusata da Stern al rientro dal fronte. Nutrita da stilemi tipici del genere come la diffidenza dell’animale (in questo caso il cane di Stern verso il padrone rientrato a casa), quella che si disegna è una variazione su quel vasto campo tematico che Massimo Fusillo ha definito della “identità sdoppiata”.
La sua architettura si incardina anche su una trama di fatti, una geometria raffinata di rimandi e di tessere in cui le esistenze di Stern e Bettuch continuano a intrecciarsi senza sosta (emblematico il caso del processo alla sorella di Bettuch nel quale viene chiesto a Stern di fornire una perizia medica). Tuttavia, il punto di maggior interesse del libro, nonché il suo più potente vettore di fantasticizzazione, risiede nella grana stessa della voce narrante, la cui centralità è rivendicata fin dal titolo, ambizioso e universale. Nel vorticoso monologo autonomo del protagonista e nella sua paratassi filante che si srotola e si attorciglia secondo ritmi scanditi dall’impiego massiccio della virgola, trova spazio una girandola di immagini crude, sregolate pulsioni d’amore e morte, accessi di depersonalizzazione.
Un’interpretazione che tenga conto del periodo storico non mancherà di mettere in relazione tale dettato e tali immagini con il trauma della guerra e del rientro dal fronte, nonché con altri elementi contestuali ricordati dalla postfazione adelphiana a firma di Manfred Posani Löwenstein: il legame con il caso Angerstein del 1924, la formazione psichiatrica dell’autore, la scomparsa al fronte del fratello Hans Mosse. Lo stesso Peter Flamm avvalora a posteriori, senza troppe sorprese, una lettura del romanzo come diagnosi dei sintomi del disagio in cui versa “l’uomo del nostro tempo”. In questo modo si finisce col fare di Wilhelm/Hans un caso clinico o quantomeno il sintomo di un disagio contingente, depotenziando le sue percezioni e riflessioni sulla base della loro origine malata: la funzione della critica diventa, paradossalmente, quella di razionalizzare e raffreddare gli ardori del testo mostrando la cornice entro il quale esso va situato.
Viceversa, le insicurezze e gli squarci aperti da certe brecce del monologare sembrano guadagnare molto in termini di efficacia qualora il lettore accetti di accoglierle in quanto tali, come qualcosa che lo riguarda e lo turba intimamente. La portata onnicomprensiva della domanda “io?” e delle sue diramazioni scoperchia questioni sull’autoreferenza e l’autoriconoscimento dalla cui formulazione nessuno può riconoscersi esente. Ciò si rende particolarmente manifesto nei pur rari passaggi in cui è la prospettiva stessa di Wilhelm/Hans ad allargarsi dal suo caso specifico fino ad abbracciare la condizione umana: «Ah, ogni vita è cieca […] i nostri occhi sono sempre rivolti verso l’esterno, ma dentro di noi c’è una caverna buia, noi stiamo lì e non riusciamo mai a vederci» (p. 54).
Anche sulla base di questa velleità del protagonista di elevare la propria esperienza a massima può farsi largo un’ipotesi ermeneutica provocatoria ma feconda: che Io? descriva non già un particolare stato di alterazione patologica post-traumatica, bensì aspetti del funzionamento normale della mente, portati verbalmente allo scoperto.
Recensione di Giovanni Salvagnini Zanazzo
Peter Flamm, Io?, traduzione dal tedesco di Margherita Belardetti, 2024, Adelphi, pp. 143, ISBN: 978-88-459-8731-1