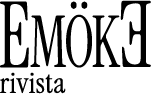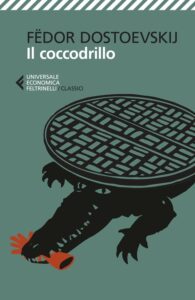
“Sempre ‘progresso’, ‘progresso’, idee d’ogni tipo, ed ecco dove porta il progresso!”
Scrive Fëdor Dostoevskij nel suo racconto Il coccodrillo, pubblicato per la prima volta nella rivista Epocha nel 1865, e pubblicato in una nuova edizione il 14 maggio 2024.
Quando scrisse Il coccodrillo, Dostoevskij, noto per il realismo psicologico dei suoi romanzi, aveva già pubblicato opere importanti come Memorie dal sottosuolo (1864) e stava per intraprendere la stesura di lavori monumentali come I demoni (1873). In quel momento della sua carriera, l’autore rifletteva sull’ambivalente modernizzazione russa e la frammentazione dell’identità nazionale che ne sarebbe seguita. La tematica, affrontata nel precedente Note invernali su impressioni estive (1863), è sviluppata in chiave umoristica nel breve racconto incompiuto, che si inserisce nell’opera dostoevskiana come una parentesi di satira e ironia.
Il racconto, inizialmente intitolato “Il marito inghiottito dal coccodrillo”, ruota attorno a un avvenimento straordinario: Ivan Matveic, un funzionario russo, viene inghiottito da un coccodrillo durante una visita a una galleria commerciale a Pietroburgo, accompagnato dalla moglie Elena Ivanova e dal narratore Semen Semenyc. Nonostante l’apparente tragedia, Ivan rimane illeso all’interno del rettile e inizia a comunicare dall’interno della bestia. I personaggi circostanti, invece di tentare di liberarlo, si concentrano su questioni economiche e di vanità, come il proprietario del coccodrillo, preoccupato per la perdita del proprio investimento, o Elena, che inizia a valutare i benefici della sua condizione di vedova (o quasi). L’ambientazione del racconto è la classica Pietroburgo dostoevskiana, presente in quasi tutti i suoi romanzi, una città in cui vivono funzionari burocratici di ogni tipo, trasformati da Dostoevskij nei protagonisti dei suoi testi.
Al modo di Note invernali su impressioni estive, ne Il coccodrillo Dostoevskij elabora la sua avversione per il trionfo della borghesia nella Russia di fine Ottocento e, soprattutto, per il “nuovo mondo”, basato sul modello capitalista occidentale, proposto dai progressisti. L’autore rivolge la sua satira a questo nuovo mondo borghese che, accanto alle prime esposizioni universali, coltiva il culto del profitto. Lontano di essere una semplice storia comica, il breve racconto di Dostoevskij esplora il tema della vanità e dell’egocentrismo, considerati dall’autore russo le conseguenze immediate del presumibile progresso arrivato dall’Occidente. Mentre l’avidità è evidenziata nel personaggio del tedesco proprietario del coccodrillo, che si preoccupa unicamente dell’animale perché è la sua fonte di guadagno, la meschinità si riflette nel protagonista Ivan, che accoglie la sua nuova condizione con entusiasmo, poiché vede nella situazione una possibilità di ottenere prestigio, riflettendo l’ironia di Dostoevskij sui presunti filosofi e teorici del progresso scientifico e del positivismo ottocentesco.
A livello formale, Dostoevskij utilizza un linguaggio satirico e ironico per sottolineare l’assurdità della situazione fantastica, che è anche, secondo l’autore, l’assurdità del crescente interesse russo per gli investimenti stranieri e il capitalismo occidentale. Il narratore in prima persona, Semen Semenyc, adotta un tono distaccato, sottolineando con indifferenza eventi straordinari. Il contrasto tra il contenuto straordinario e lo stile narrativo genera un effetto comico all’interno della narrativa, mettendo in luce lo straordinario umorismo di Dostoevskij, preservato nella versione italiana dall’ottima traduzione di Serena Prina.
L’autore delinea una magistrale combinazione tra critica sociale, umorismo ed elementi surreali nel racconto, il che rende Il coccodrillo un’opera unica nel corpus dostoevskiano, offrendo spunti di riflessione sulle contraddizioni sociali della Russia dell’epoca.
Recensione di Giovanna de Campos Mauro
Fëdor Dostoevskij, Il coccodrillo, traduzione dal russo di Serena Prina, 2024, Feltrinelli, pp. 97, ISBN: 9788807904783