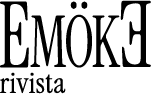McGlue
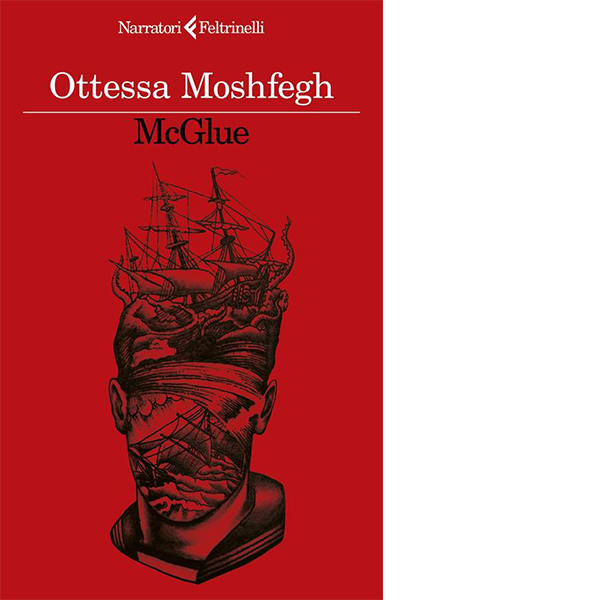
“Un sorso di sangue è un buon sostituto. Quello di Johnson sa di rum. Il mio più di vino rancido. Ascolto il fischio nelle orecchie e guardo la neve.” Ottessa Moshfegh è una scrittrice statunitense che spicca nel panorama letterario contemporaneo per l’attrazione che prova nei confronti delle parti più crude, oscure e perturbanti dell’essere umano, affrontate con un sorprendente velo di umorismo. Conosciuta in particolare per il premiato Eileen (2015), per il bestseller Il mio anno di riposo e oblio (2019) ed il più recente Lapvona (2022), Moshfegh vede ora pubblicato in Italia McGlue, il suo romanzo d’esordio del 2014, tradotto da Gioia Guerzoni per Feltrinelli. In questo romanzo breve, Moshfegh sperimenta attraverso il punto di vista, ovvero quello di un alcolizzato dai ricordi confusi. Questa scelta stilistica inusuale rende interessante una trama altrimenti semplice: un uomo è accusato di averne ucciso un altro. I due personaggi in questione sono McGlue, nella cui testa siamo intrappolati dall’inizio alla fine del racconto, e Johnson, che non è una semplice vittima, ma il migliore amico del protagonista, per il quale il narratore sembra provare qualcosa di più profondo, viscerale, di cui cogliamo la potenza solo attraverso la nebbia dei suoi ricordi, pensieri ed allucinazioni. La tensione omoerotica tra i due si intreccia con il terribile crimine di cui McGlue viene accusato, che non solo non ricorda, ma a cui addirittura non riesce a credere possibile per gran parte del romanzo. Dal confronto con le pubblicazioni successive dell’autrice, emerge la sensazione che questa prima prova, pur nella sua maturità, sia un punto di partenza per una scrittura più consapevole. L’alcolismo che viviamo nelle pagine di McGlue, infatti, richiama la dipendenza da barbiturici della protagonista di Il mio anno di riposo e oblio. L’attenzione di Moshfegh per il torbido, che disgusta e al contempo attrae, presente in scene come quella in cui Mcglue tenta di raschiare il proprio cervello con un coltello, alla disperata ricerca di ricordi, si può definire come un semplice “assaggio” se paragonato all’ossessione per il macabro che si riscontra in Lapvona. In quello che per alcuni aspetti si potrebbe definire un thriller psicologico, Moshfegh ci fa vivere lo strazio di una dipendenza dall’alcol, segnata da una sintassi a singhiozzo, che richiama proprio quello tipico di un ubriacone. Infatti, il flusso di pensieri del protagonista, in cui veniamo immersi così in profondità da rendere talvolta labile il confine tra noi e lui, appare sconnesso, difficile da seguire, travolge il lettore con continui cambi di direzione. Questa sensazione di annegare, la mancanza d’aria che proviamo sott’acqua o quando abbiamo il singhiozzo, sono, d’altronde, la diretta conseguenza della scelta del punto di vista alla base dell’opera ma che, in contrapposizione a questa difficoltà della lettura, hanno il pregio di farci immedesimare con il protagonista, facendoci vivere in prima persona le sue emozioni, i suoi desideri e le sue paure. Ci permettono di sentire il fragore dell’acqua, lo sciabordio della nave, l’instabilità data dall’ubriachezza e dalle onde che smuovono una nave in mezzo all’oceano. Più che di coscienza, quello di McGlue si potrebbe definire come un “flusso di incoscienza”, fatto di immagini e sensazioni annebbiate dall’alcol, dal dolore di una ferita fisica e di una ferita dell’anima, che forse nasconde un segreto così oscuro da non volerlo credere, tanto meno ricordare. Si può arrivare ad uccidere chi ci ha salvato? McGlue è una lettura che riesce a sorprendere, soprattutto se ci si lascia travolgere dalla sua impetuosa e tormentata corrente. Recensione di Adele Rudella Ottessa Moshfegh, McGlue, traduzione dall’inglese di Gioia Guerzoni, 2024, Feltrinelli, pp. 134, ISBN: 9788807035760
Il mondo che ha fatto

“È tutto un frattempo oggi.” La scrittura è un atto di risarcimento, un modo per restituire presenza a chi la vita ha allontanato. Il mondo che ha fatto (2025) di Roberto Ferrucci è un libro che custodisce il legame di un’amicizia, l’esperienza di due scrittori che interrogano il mondo, lo sguardo che con delicatezza attraversa le immagini della memoria. Roberto Ferrucci ha esordito nel 1993 con il romanzo Terra rossa (Transeuropa), a cui sono seguiti Giocando a pallone sull’acqua (Marsilio, 1999) e Andate e ritorni, scorribande a nordest (2003). Nel 2007 pubblica Cosa cambia, con un’introduzione di Antonio Tabucchi, poi tradotto in Francia. Oltre alla sua attività di scrittore, è noto per le sue traduzioni di autori francesi come Jean-Philippe Toussaint e Patrick Deville. Dal 2002 insegna scrittura creativa all’Università di Padova. Tra le sue opere più recenti figurano Venezia è laguna (2019), una riflessione sulla fragilità della sua città natale, e Storie che accadono (2022), un omaggio ad Antonio Tabucchi. In molte di queste tappe Ferrucci è accompagnato da un amico, uno scrittore e interlocutore d’eccezione: Daniele Del Giudice. Il mondo che ha fatto è il suo ultimo libro, edito per La nave di Teseo, candidato su proposta di Claudio Magris al Premio Strega 2025. Un libro di difficile classificazione: non è solo un memoir, né un saggio, né una semplice raccolta di ricordi. È un’opera stratificata, un mosaico di esperienze, definito dall’autore stesso come «un libro a cassetti, i miei, caotici, come la memoria, come la vita». All’interno, la storia di un rapporto d’amicizia, quello tra Roberto e Daniele, nel quale Del Giudice viene raccontato attraverso un punto di vista inedito, tramite una narrazione che va oltre un resoconto biografico, creando un dialogo sul senso del narrare. Il narratore ha venticinque anni e si trova nella libreria di Mestre, la Don Chisciotte, dove incontra il trentaseienne Daniele. Da qui si instaurano una serie di tasselli che andranno a creare un disegno condiviso: “Daniele postilla i racconti di Roberto, Roberto presenta in pubblico i libri di Daniele, Daniele dà i suoi scritti a Roberto, Roberto fa la tesi di laurea su Daniele” (Tiziano Scarpa). L’autore riporta, con la stessa meticolosità che caratterizza la scrittura di Del Giudice, le conversazioni, le cartelle che trova nel sacco condominiale delle immondizie, i fogli di Daniele, le presentazioni e le immagini, poche ma preziose, reliquie di un passato condiviso. Non solo: Roberto informa il lettore sulle modalità con cui reperisce certi dati e dove si trova nel momento in cui mette insieme il mondo che ha fatto, privilegiando un bar che si affaccia alla casa di cura dove Daniele vive gli ultimi dieci della sua vita, di fronte al parco di San Giorgio. Sono pagine in cui fin dall’inizio l’autore si avvicina con delicatezza alla drammaticità di uno scrittore che in pochi anni «dimentica tutte le parole. Proprio lui che le parole, nei suoi libri, le aveva portate al massimo livello di precisione e vividezza, catturando la complessità tecnologica e sentimentale del nostro tempo». Ecco che allora, proprio tramite la scrittura, Roberto Ferrucci compone un ritratto composito e profondo di Daniele Del Giudice, attraversando la dimensione più quotidiana. Come in tutte le amicizie, il loro legame diviene motore di una rete di incontri che Ferrucci descrive con occhi partecipi ma non invadenti, lasciando ai dettagli di un gesto o di un silenzio il compito di restituire un ricordo. Come quello a Viareggio, con il loro amico regista Wim Wenders, o come l’appuntamento con Mathieu Amalric, regista de Lo stadio di Wimbledon (2001), che dalla scrittura di Del Giudice trae ispirazione per il suo film, «girato pagina dopo pagina». E ancora, a Venezia, durante il progetto Fondamenta, la visione di Ágota Kristóf, che Ferrucci descrive con la sensibilità di chi è consapevole della necessità di lasciare spazio al silenzio. A campo Sant’Angela la si può vedere seduta a fumare una sigaretta, isolata, quasi fuori fuoco «seduta lì, appartata, fuori quadro, e lei sembrava assomigliare in quel momento ai suoi libri. Meglio, sembrava la sua scrittura. Semplice, essenziale, netta. E però evanescente, anche. Non per quel che scriveva, ma per come scriveva». Cosa resta di uno scrittore dopo le sue parole, i ricordi di una vita che si mescolano? «Gli scrittori – si sa – ci lasciano prima di tutto i libri che hanno scritto», osserva Ferrucci, «Se uno scrittore è poi anche tuo amico, ti lascia molto altro. Quante volte con Daniele abbiamo parlato delle cose, degli oggetti, di come descriverli e nominarli e raccontarli nei libri – i nomi, le cose». Roberto ripercorre gli oggetti che i due hanno condiviso come il cronografo, la macchina da scrivere Underwood e ciò che di più intimo gli è rimasto: il taccuino color sabbia, una cartolina dal suo viaggio in Antartide, il manoscritto Terra rossa, primo romanzo di Ferrucci, appuntato da Del Giudice. È nella misura, nei dettagli e nella precisa scelta delle parole che si rivela la profondità dello sguardo di Ferrucci. La sua scrittura non indugia nella retorica del dolore, ma mantiene un equilibrio sottile tra partecipazione emotiva e sorveglianza formale. Come ha scritto Magris, «leggendo il libro si entra in un’officina del romanzo, in cui le varie situazioni narrative e le diverse figure scivolano come le parole del romanzo stesso, in un susseguirsi di eventi che si fondono nella narrazione». Recensione di Sofia Crincoli Roberto Ferrucci, Il mondo che ha fatto, 2025, La nave di Teseo, pp. 336, ISBN: 8834619811
You Like It Darker
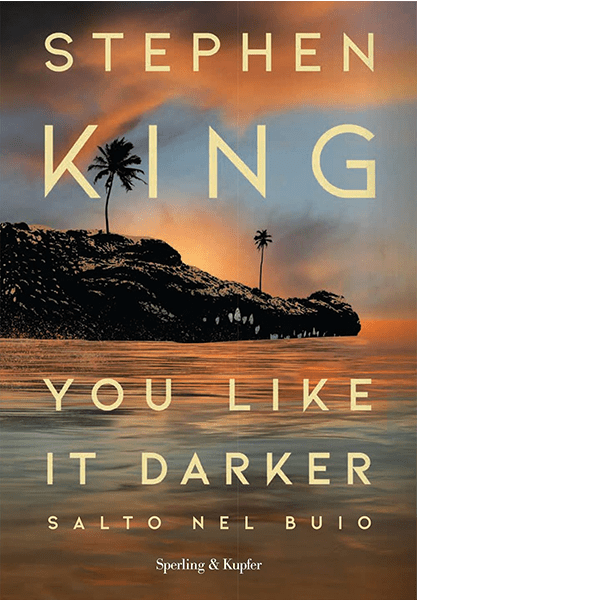
“Vi piace il buio? Bene. Anche a me, e questo fa di me la vostra anima gemella.” Così scrive Stephen King nella postfazione della sua tredicesima antologia di racconti, pubblicata il 21 maggio 2024. Con oltre 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Stephen King è il più prolifico scrittore statunitense. Con la sua nuova raccolta, King dimostra di essere ancora al culmine della sua carriera e giustifica la sua persistente reputazione come “maestro dell’Horror”. In You Like It Darker. Salto nel Buio, l’autore approfondisce i temi portanti della sua opera e riprende i personaggi e le ambientazioni di alcuni testi precedenti, come Cujo (1981) e Duma Key (2008). Tra racconti inediti e altri previamente già pubblicati, You Like It Darker. Salto nel Buio è originale nel suo genere appunto perché, oltre all’horror tradizionale, sviluppato magistralmente in scene che uniscono immagini perturbanti ed elementi soprannaturali, le storie di King affrontano l’horror da una prospettiva diversa, esplorando temi universali come il lutto, il dolore, la fortuna, le ambiguità della verità e il senso della vita. Si tratta, dunque, di un’opera essenzialmente umana. Due bastardi di talento racconta la storia del segreto dietro il successo di due amici e, anche se non particolarmente notevole, è la scelta giusta per aprire l’opera e impostare il suo tono. Con la sua narrativa sull’alcolismo, Il quinto passo è uno dei racconti più brevi della raccolta, mentre Willy lo Strambo segue un bambino e il suo peculiare fascino per la violenza. Un ragazzo colpito dalla sfortuna è il protagonista di Finn, collegata alle altre storie tramite la discussione sulle ambiguità del reale. Lungo Slide Inn Road racconta il viaggio di una famiglia per salutare una zia malata e, ne Lo Schermo Rosso, Leonard Crocker uccide la moglie, sostenendo che un alieno abbia preso possesso del suo corpo. Riportando i lettori al tema dei viaggi aerei de I Langolieri (1990), L’esperto di turbolenze racconta la storia di Craig Dixon e il suo mestiere di salvare gli aerei colpiti da turbolenze. Unico nella raccolta per la sensibilità dimostrata da King nel modo di affrontare la scelta tematica, Laurie è, inoltre, un racconto sui temi dell’invecchiamento e del lutto. Nella raccolta, la struttura dei racconti brevi limita l’uso esteso di ambientazioni e personaggi e pone l’accento sulla trama e sui colpi di scena, invitando il lettore a riflettere su temi universali. L’incubo di Danny Coughlin è stata una delle storie più apprezzate dalla critica ed è anche una delle più rappresentative della raccolta. Danny Coughlin decide di segnalare anonimamente l’omicidio di una donna, dopo averlo sognato, ma diventa il suo principale sospettato. Il racconto è magistrale nell’indagare costantemente la linea sottile che distingue il reale dal non reale, spesso simboleggiata nell’insieme di storie dal sogno e dalla problematica della post-verità: Sono rimasto anche quando sapevo che stavamo oltrepassando la linea di demarcazione tra la sanità mentale e la follia. I tre ultimi racconti di You Like It Darker. Salto nel Buio dimostrano l’essenza della letteratura di King: un’analisi profonda delle paure umane e delle ambiguità esistenziali attraverso una narrazione che destabilizza il confine tra realtà e soprannaturale. Riprendendo Cujo, Serpenti a sonagli presenta le vicende inquietanti di Vic Trenton in una località isolata della Florida, ed è la storia soprannaturale più affascinante della raccolta. I limiti della scienza, i sogni e la realtà sono i temi centrali di I sognatori, uno dei più coinvolgenti della collettanea. Nel racconto, un giovane lavora per uno scienziato che vuole fare esperimenti sui sogni alla ricerca ossessiva del significato dell’universo. Infine, L’Uomo delle Risposte è la grandiosa conclusione di You Like It Darker ed è, a parere di chi scrive, il più interessante racconto mai scritto da Stephen King. Il racconto è ambientato in tre momenti della vita di Phil Parker: le tre volte in cui incontrato il misterioso “uomo delle risposte”. Sebbene non rientri nei canoni dell’horror tradizionale, L’Uomo delle Risposte si distingue come il racconto più inquietante della raccolta per la sua intrigante rappresentazione della condizione umana. In You Like It Darker Stephen King dimostra una notevole maestria nell’intrecciare una varietà di storie che si distinguono per loro varietà di stili e livelli di intensità emotiva e per l’ampia gamma di narrazioni, dalle trame più cupe e inquietanti alle più leggere, creando un contrasto che arricchisce l’esperienza della lettura. King riesce a orchestrare un insieme di racconti che non soltanto si completano a vicenda, ma elevano la qualità complessiva dell’opera, confermandola come una delle uscite più rilevanti del genere horror fiction nel 2024. Recensione di Giovanna De Campos Mauro Stephen King, You Like It Darker. Salto nel Buio, traduzione dall’inglese di Luca Briasco, 2024, Sperling & Kupfer, pp. 544, ISBN: 978-8820079437
Io?
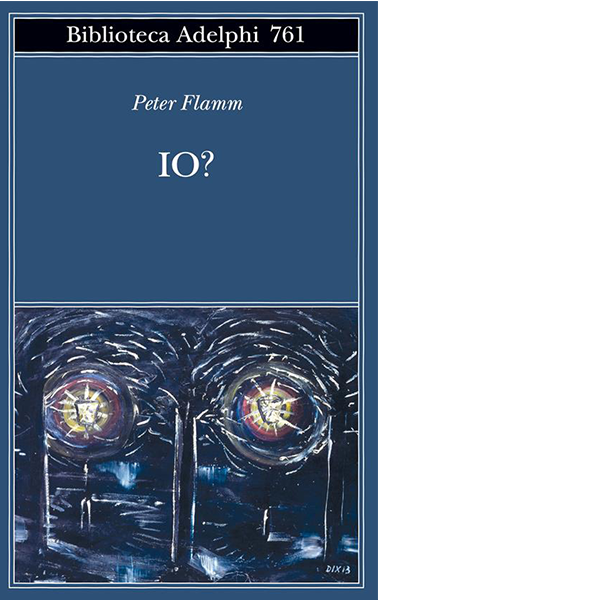
Esiste un conflitto perenne, più o meno latente, tra la teoria letteraria e la storia. Io? (Ich?) Il romanzo d’esordio dell’espressionista tedesco Peter Flamm, pubblicato per la prima volta in Italia da Adelphi in concomitanza con la nuova edizione tedesca Fisher, lo fa emergere con forza in sede di interpretazione. Uscito originariamente nel 1926, il libro porta ben visibili tutti i segni del suo periodo storico narrando la vicenda di un sopravvissuto della Prima guerra mondiale, il fornaio Wilhelm Bettuch, che recupera i documenti e l’identità di un cadavere, quello dell’agiato medico Hans Stern, per poi rientrare nella vita civile al posto di quest’ultimo, nella sua famiglia, incontrando svariate difficoltà di reinserimento in società. Tale spunto narrativo, raccontato dal punto di vista soggettivo e inaffidabile del protagonista, genera un’atmosfera fantastica, un soprannaturale di esitazione in cui il lettore si trova perennemente in bilico tra la fede nella versione della voce narrante (che si pone come Bettuch, l’usurpatore di un’identità rubata) e il sospetto di una pazzia tout-court accusata da Stern al rientro dal fronte. Nutrita da stilemi tipici del genere come la diffidenza dell’animale (in questo caso il cane di Stern verso il padrone rientrato a casa), quella che si disegna è una variazione su quel vasto campo tematico che Massimo Fusillo ha definito della “identità sdoppiata”. La sua architettura si incardina anche su una trama di fatti, una geometria raffinata di rimandi e di tessere in cui le esistenze di Stern e Bettuch continuano a intrecciarsi senza sosta (emblematico il caso del processo alla sorella di Bettuch nel quale viene chiesto a Stern di fornire una perizia medica). Tuttavia, il punto di maggior interesse del libro, nonché il suo più potente vettore di fantasticizzazione, risiede nella grana stessa della voce narrante, la cui centralità è rivendicata fin dal titolo, ambizioso e universale. Nel vorticoso monologo autonomo del protagonista e nella sua paratassi filante che si srotola e si attorciglia secondo ritmi scanditi dall’impiego massiccio della virgola, trova spazio una girandola di immagini crude, sregolate pulsioni d’amore e morte, accessi di depersonalizzazione. Un’interpretazione che tenga conto del periodo storico non mancherà di mettere in relazione tale dettato e tali immagini con il trauma della guerra e del rientro dal fronte, nonché con altri elementi contestuali ricordati dalla postfazione adelphiana a firma di Manfred Posani Löwenstein: il legame con il caso Angerstein del 1924, la formazione psichiatrica dell’autore, la scomparsa al fronte del fratello Hans Mosse. Lo stesso Peter Flamm avvalora a posteriori, senza troppe sorprese, una lettura del romanzo come diagnosi dei sintomi del disagio in cui versa “l’uomo del nostro tempo”. In questo modo si finisce col fare di Wilhelm/Hans un caso clinico o quantomeno il sintomo di un disagio contingente, depotenziando le sue percezioni e riflessioni sulla base della loro origine malata: la funzione della critica diventa, paradossalmente, quella di razionalizzare e raffreddare gli ardori del testo mostrando la cornice entro il quale esso va situato. Viceversa, le insicurezze e gli squarci aperti da certe brecce del monologare sembrano guadagnare molto in termini di efficacia qualora il lettore accetti di accoglierle in quanto tali, come qualcosa che lo riguarda e lo turba intimamente. La portata onnicomprensiva della domanda “io?” e delle sue diramazioni scoperchia questioni sull’autoreferenza e l’autoriconoscimento dalla cui formulazione nessuno può riconoscersi esente. Ciò si rende particolarmente manifesto nei pur rari passaggi in cui è la prospettiva stessa di Wilhelm/Hans ad allargarsi dal suo caso specifico fino ad abbracciare la condizione umana: «Ah, ogni vita è cieca […] i nostri occhi sono sempre rivolti verso l’esterno, ma dentro di noi c’è una caverna buia, noi stiamo lì e non riusciamo mai a vederci» (p. 54). Anche sulla base di questa velleità del protagonista di elevare la propria esperienza a massima può farsi largo un’ipotesi ermeneutica provocatoria ma feconda: che Io? descriva non già un particolare stato di alterazione patologica post-traumatica, bensì aspetti del funzionamento normale della mente, portati verbalmente allo scoperto. Recensione di Giovanni Salvagnini Zanazzo Peter Flamm, Io?, traduzione dal tedesco di Margherita Belardetti, 2024, Adelphi, pp. 143, ISBN: 978-88-459-8731-1
Sfinge
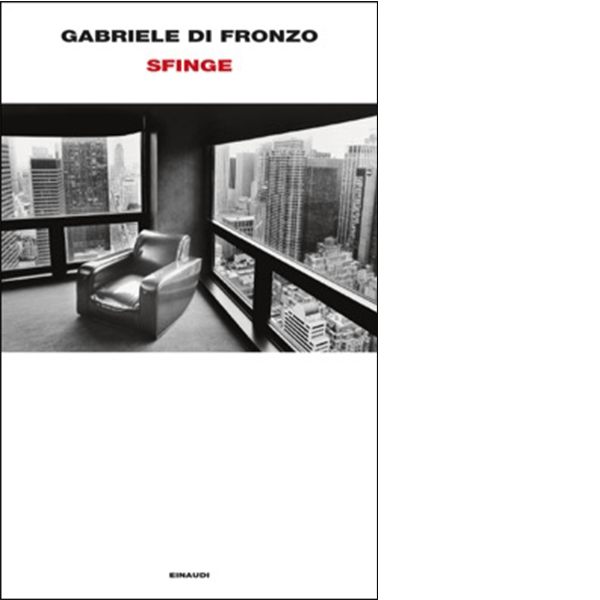
“In un preciso momento la materia inorganica, che si decompone e muta costantemente, altererà anche la Sfinge, e proprio in vista di quel momento devo tenere i miei occhi ben piantati su di lei, per essere presente quando diventerà ciò che da tre millenni desidera diventare: polvere.” Sfinge, quarto libro di Gabriele Di Fronzo (il premiato esordio per nottetempo, con Il grande animale, risale al 2016), non soltanto è davvero un romanzo, ma per giunta è un romanzo di rara pregevolezza, nel cui intreccio, e soprattutto nella cui lingua, si rinviene qualcosa di felicissimo: la cura. È questa, saldata ad una certa dose di ironica sobrietà, a far tutta la differenza fra uno stile povero e uno stile elegante; fra un intreccio e dei personaggi ben orchestrati, che reggono graniticamente alla prova del lettore, e altri che invece si sgretolano alla prima colluttazione. La storia narrata è quella di Matteo Lesables, archeologo mancato, prossimo ai sessant’anni e courier per il Museo Egizio di Torino, incaricato – forse per l’ultima volta – di accompagnare un reperto all’estero: ma il reperto non è il solito reperto, e l’estero non è l’estero a cui Matteo è uso. Portare la Sfinge a Shanghai, e vegliarla per una settimana (fino all’inizio di un’importante mostra dedicata ai tesori dell’antichità), costringe Matteo a fare i conti con il proprio passato, con un matrimonio finito tragicamente, una vita passata a fare lo straniero nei musei di tutto il mondo, e soprattutto con il senso del proprio mestiere. Se certe città sono infatti come grandi esposizioni museali a cielo aperto, Shanghai sembra rifiutare invece ogni linearità fra i secoli, ogni principio cognitivo di permanenza oggettuale: Qualunque straniero a Shanghai, dopo essere sceso dall’aereo, potrebbe scrivere una prima lettera in cui dice di aver appena scoperto un mondo che altrove non è ancora comparso; quello stesso straniero, a distanza di un unico pomeriggio in città, potrebbe spedire una seconda lettera in cui giura di aver appena incontrato un mondo che altrove è scomparso per sempre. Parallelamente, il protagonista viene incalzato da un presente brulicante, che si presenta sotto la guisa di venditori di tartarughe, di edifici e intere realtà che sembrano soggiogare il paesaggio circostante «con l’intelletto anziché con la forza», di una fatale attrazione per Qi (direttrice dello Shanghai History Museum), e infine di una proposta catartica: trasportare, per la prima volta nella vita, «qualcosa che non soltanto può rompersi e danneggiarsi, ma che può addirittura morire». Non si dica altro sulla trama, pena la banalizzazione. Lo stile è, si diceva, curato: l’effetto di una lingua piana, nella sintassi e nell’incedere, è qui solo apparente, giacché ciascuna delle tessere che la compongono presenta uno scarto nel segno della ricercatezza, del tecnicismo (attentissimo ai materiali, alle questioni di mestiere…) – così la voce narrante di Matteo Lesables riesce a credersi effettivamente quella di un courier sessantenne vagamente abbacchiato, temprato nella professione e di ampie letture, e rifugge il dramma di tanti protagonisti che parlano sempre e soltanto, libro dopo libro, come chi li crea. Una qualche variatio espressiva è sempre garantita, anche nei passaggi di maggior riflessività e rallentamento (sia narrativo sia linguistico), da metafore, similitudini, proverbi cinesi – immagini talvolta basse, vitalistiche e di grande espressività, ma assolutamente inattese: così ad esempio un’interprete può trovarsi, nel mezzo di un momento carico di pathos, «stravaccata come una bambina ammalata che guarda la televisione dopo aver fatto colazione». Nel complesso, Di Fronzo sembra disporre continuamente, più che del mot, di una image juste – si sceglie questo termine per via della sua capacità di evocare anche una certa visività presente nel romanzo, dal piglio spesso cinematografico –, e più in generale di un pensiero analogico sempre operante nelle retrovie, di cui è dimostrazione il parallelismo, con cui si vuol chiudere questo lieto responso, tracciato da Matteo fra il viaggiatore (e il particolarissimo tipo di viaggiatore che è il courier) ed il fantasma: Contrariamente a quello che si ritiene facciano i fantasmi, che pare ritornino ai luoghi dove in vita hanno sotterrato i propri tesori, il viaggiatore da quei tesori si allontana più che può. Forse così facendo si crede immortale. Io che viaggio con i miei tesori accanto, in quale tipo di fantasma mi risveglierò? Recensione di Gian Marco Evangelisti Gabriele Di Fronzo, Sfinge, 2025, Einaudi, pp. 224, ISBN: 9788806263836
Il vecchio al mare
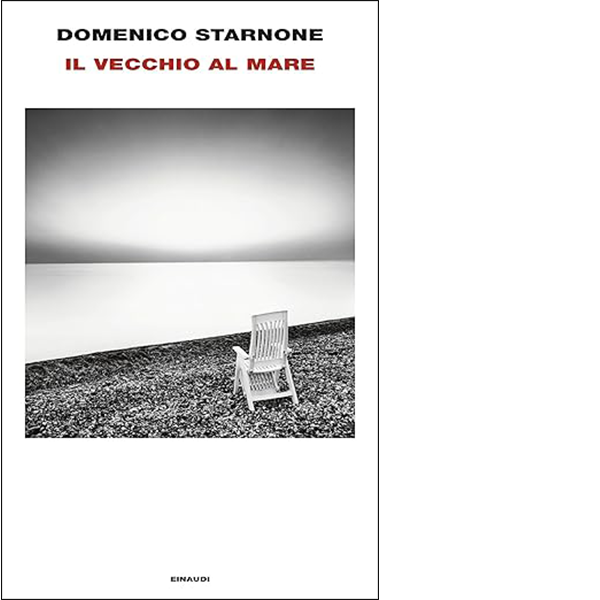
“Quindi mi sono concesso un lungo sospiro, ho estratto dalla borsa il quaderno, mi sono calcato per bene il cappello in testa e ho scritto di ciò che mi era successo, senza badare più al mare, ai granelli di sabbia che spinti dal vento caldo mi stavano smerigliando le caviglie.” È una calda mattina d’ottobre quando il disilluso ottantaduenne Nicola Gamurra, dirigendosi in spiaggia, il borsone e la sedia pieghevole in spalla, la vede: «una figurina dai contorni d’oro», di cui a stento riesce a dare una definizione, pur riconoscendone all’istante la più profonda natura. Si tratta di un’energetica ventiquattrenne, di nome Lu, che quasi tutte le mattine porta in mare una canoa rossa; e che pagaiando risveglia nell’anziano il ricordo della madre, prematuramente scomparsa. Nicola inizia a sentirsi un figlio «al passato remoto», mentre vede il mistero materno sciogliersi al futuro, nel corpo e nei moti di una ragazza che pur non le somiglia in nulla. Questo è, in poche parole, il nucleo del nuovo romanzo di Domenico Starnone, Il vecchio al mare (Einaudi, 2024), la cui vicinanza con Il vecchio e il mare di Hemingway è voluta, ma per fini ironici: nulla di quanto succede al vecchio Santiago si prospetta infatti a Nicola – nessuna lotta titanica con la natura (se non con quella più profonda della vecchiaia). Semplicemente, una piccola località costiera con i suoi piccoli segreti (un marito fedifrago, un professore licenziato…), ed un’estrema sensibilità e delicatezza. La carriera di Starnone prende avvio nel 1987 con il romanzo Ex cattedra, nutrito della sua lunga esperienza come insegnante, e si allarga presto al piccolo e al grande schermo, tra adattamenti dei suoi testi e sceneggiature originali. Nel 2001 il romanzo Via Gemito (2000) gli vale il Premio Strega e un posto come finalista al Campiello. La sua ampia produzione narrativa raccoglie anche, tra i molti, Denti (1994), Labilità (2005), Lacci (2014) e Confidenza (2019), cui non nuoce affiancare il più recente e saggistico L’umanità è un tirocinio (2023). Il vecchio al mare nasce dalla commistione di maturità letteraria e maturità anagrafica, sulla quale vengono innestati temi cari all’autore e già disseminati nelle sue opere: l’amore, il passato, la ricerca di speranza. Trionfa ovviamente la riflessione sulla vecchiaia, ma un ruolo altrettanto centrale è dedicato ai dettagli, alla minuta quotidianità italiana, e soprattutto a quella famigliare – ricordata e osservata –, nel bene e nel male. Alla ricerca di una dimessa autenticità rappresentativa corrispondono nel testo le riflessioni del protagonista sulla propria scrittura: Ho detto a me stesso: se non ho le qualità necessarie per le cose grandi, mi concentrerò sulle piccole e ci lavorerò con le carabattole che ho sottomano. E così là, nel mio incavo, raggomitolato, spalle curve come la cima di una roncola, ho assemblato fino a oggi – badando a non salire mai di tono, a non fingere di saperla lunga – donnette e ometti senza fisica e astrofisica, senza algebra e chimica, senza scienza della propria anima e di quella altrui… Nell’incedere calmo della prosa si delinea un elogio dei tempi lenti, l’anelito ad una quiete che non può mai essere, almeno per Nicola, né interna né esterna: innanzitutto poiché non riesce ad estinguere alcuni desideri, come quello di ritrovare la madre nelle donne della propria vita. Ma al contempo la felicità, o almeno una divertita tranquillità, si lascia intravedere, come un lampo, nell’attimo in cui l’immaginazione potenzia la realtà senza nasconderla o falsarla, senza ingabbiarla in trame predisposte. Così il vecchio giustifica la fantasia operante in Niní, il figlioletto di Lu, quando s’immagina una piovra gigante in mare: «le storie sono belle e utili proprio perché abituano la testa a non accontentarsi delle apparenze, a cercar oltre». E sempre così può egli gioire, mentre Lu gli insegna a pagaiare, sentendosi una rara fusione di «polietilkevlarcarnevecchiacarnegiovanefigliofigliamadremarevitamorte», autentico e freudiano mostro marino. Recensione di Gian Marco Evangelisti Domenico Starnone, Il vecchio al mare, 2024, Einaudi, pp. 122, ISBN: 9788806255817
Non dico addio

“Sento un freddo improvviso da cui neanche due maglioni e due cappotti possono ripararmi. Un gelo che sembra provenire non da fuori, ma dal mio petto. Il mio corpo è scosso dai brividi, e nell’istante in cui tutto nella stanza ondeggia al ritmo della fiamma che trema nella mia mano, capisco perché In-seon, quando gliel’ho chiesto, ha negato immediatamente ogni volontà di trarre un film da questa vicenda. Il tanfo di carne e vestiti intrisi di sangue che si decompongono insieme sarà cancellato, come la fosforescenza di ossa erose dai decenni. Gli incubi scivoleranno via tra le dita. La violenza al di là d’ogni limite sarà rimossa.” Narrazione come argine all’oblio: questo è Non dico addio, romanzo di Han Kang incentrato sull’eccidio avvenuto sull’isola di Jeju nel 1948-1949. In piena concordanza con una tensione propria della narrativa nell’estremo contemporaneo e secondo una sensibilità già manifestata in Atti umani (2017), storia nazionale e finzione romanzesca sono infatti indissolubilmente collegate in quest’ultima pubblicazione della pluripremiata autrice sudcoreana. Non dico addio si colloca come punto di arrivo – tanto cronologico, quanto di elaborazione formale – nella sua produzione: recentemente insignita del premio Nobel per la Letteratura 2024, Kang ha infatti esordito sulla scena letteraria negli anni novanta, cimentandosi dapprima con la poesia, per poi passare alla prosa e, nello specifico, alla stesura di racconti, saggi e romanzi. Tra questi ultimi si ricordano La vegetariana (2016), libro con cui ha vinto il Man Booker Prize ed è divenuta nota al pubblico internazionale, e il già citato Atti Umani, in quanto in Non dico addio tornano temi in essi centrali, quali rispettivamente i rapporti tra figure femminili e un’indagine sulla corporeità e i traumi storici e la loro messa in forma letteraria. Il romanzo narra una storia piuttosto semplice: la protagonista Gyeong-ya, dopo aver ricevuto un messaggio dall’amica In-Seon, si reca in ospedale a trovarla e riceve da quest’ultima il compito di andare a casa sua per tentare di salvare il suo uccellino, mentre fuori imperversa una tempesta di neve. Ciò che però colpisce della narrazione è la continua fluttuazione dei confini tra sogno e realtà e tra passato e presente: Gyeong-ya è infatti sola per gran parte del romanzo, ma complici il suo malessere e la stanchezza, si abbandona spesso al sonno o all’allucinazione, stati di alterazione della coscienza che le permettono di raggiungere verità insondate sull’identità di In-Seon, sul rapporto di quest’ultima con la madre e sulla loro amicizia. Secondo Kang, Non dico addio è infatti «un romanzo d’amore», definizione che trova piena corrispondenza con la riscoperta dei legami affettivi in esso tematizzata, ma anche col recupero di pagine tragiche del passato della Corea del Sud, operazione che ha come motivazione diegetica il vissuto della madre di In-Seon: la protagonista si impegna infatti a riempire le lacune lasciate dalle narrazioni ufficiali e ad evitare che le vittime vengano dimenticate, secondo un proposito che dà il titolo all’opera. Lo stile adottato dall’autrice oscilla come di consueto tra il crudo realismo e una certa rarefazione linguistica: il ricorso ad un lessico schiettamente sanguinolento non è infatti ascrivibile al mero gusto contemporaneo per il pulp, ma è al contrario funzionale alla restituzione di immagini non edulcorate delle stragi. Lo bilanciano spinte liriche che fanno leva, ad esempio, su elementi naturali del paesaggio: così la neve – vero e proprio leitmotiv del romanzo – è il manto leggero e impalpabile, metafora di fragilità e dimenticanza, laddove gli alberi – che compaiono spesso in forma umanizzata – simboleggiano presenza e memoria. Questi ultimi sono solo due degli aspetti che, con la loro ricorsività, tengono unita la narrazione, la quale risulterebbe altrimenti eccessivamente frammentata: la narratrice omodiegetica Gyeong-ya traccia infatti dei fili invisibili tra ciò che è stato e ciò che è, dislocando immagini traumatiche – come le dita amputate di In-Seon – o aspetti che la ossessionano tanto positivamente – come lo juk, uno dei pochi cibi che ancora le suscita appetito – quanto negativamente – come la marea che tutto oblia. Il risultato è un romanzo in cui il desiderio di gettare luce sul passato collettivo e di ricomporre l’informità delle testimonianze e degli eventi si ripercuote sulla vita emotiva e psichica della protagonista, la quale sin dall’inizio della narrazione constata: quel mare livido che saliva, strappando le ossa alle loro sepolture, probabilmente non c’entrava nulla con le vittime del massacro e il periodo successivo. Poteva anche trattarsi di un semplice presagio personale. Forse quel paesaggio di tombe sommerse e lapidi silenziose mi stava rivelando cosa aspettarmi dalla mia vita in futuro. Ovvero, precisamente adesso. Recensione di Serena Scolari Han Kang, Non dico addio, traduzione dal coreano di Lia Iovenitti, 2024, Adelphi, pp. 265, ISBN: 9788845939327
Il coccodrillo

“Sempre ‘progresso’, ‘progresso’, idee d’ogni tipo, ed ecco dove porta il progresso!” Scrive Fëdor Dostoevskij nel suo racconto Il coccodrillo, pubblicato per la prima volta nella rivista Epocha nel 1865, e pubblicato in una nuova edizione il 14 maggio 2024. Quando scrisse Il coccodrillo, Dostoevskij, noto per il realismo psicologico dei suoi romanzi, aveva già pubblicato opere importanti come Memorie dal sottosuolo (1864) e stava per intraprendere la stesura di lavori monumentali come I demoni (1873). In quel momento della sua carriera, l’autore rifletteva sull’ambivalente modernizzazione russa e la frammentazione dell’identità nazionale che ne sarebbe seguita. La tematica, affrontata nel precedente Note invernali su impressioni estive (1863), è sviluppata in chiave umoristica nel breve racconto incompiuto, che si inserisce nell’opera dostoevskiana come una parentesi di satira e ironia. Il racconto, inizialmente intitolato “Il marito inghiottito dal coccodrillo”, ruota attorno a un avvenimento straordinario: Ivan Matveic, un funzionario russo, viene inghiottito da un coccodrillo durante una visita a una galleria commerciale a Pietroburgo, accompagnato dalla moglie Elena Ivanova e dal narratore Semen Semenyc. Nonostante l’apparente tragedia, Ivan rimane illeso all’interno del rettile e inizia a comunicare dall’interno della bestia. I personaggi circostanti, invece di tentare di liberarlo, si concentrano su questioni economiche e di vanità, come il proprietario del coccodrillo, preoccupato per la perdita del proprio investimento, o Elena, che inizia a valutare i benefici della sua condizione di vedova (o quasi). L’ambientazione del racconto è la classica Pietroburgo dostoevskiana, presente in quasi tutti i suoi romanzi, una città in cui vivono funzionari burocratici di ogni tipo, trasformati da Dostoevskij nei protagonisti dei suoi testi. Al modo di Note invernali su impressioni estive, ne Il coccodrillo Dostoevskij elabora la sua avversione per il trionfo della borghesia nella Russia di fine Ottocento e, soprattutto, per il “nuovo mondo”, basato sul modello capitalista occidentale, proposto dai progressisti. L’autore rivolge la sua satira a questo nuovo mondo borghese che, accanto alle prime esposizioni universali, coltiva il culto del profitto. Lontano di essere una semplice storia comica, il breve racconto di Dostoevskij esplora il tema della vanità e dell’egocentrismo, considerati dall’autore russo le conseguenze immediate del presumibile progresso arrivato dall’Occidente. Mentre l’avidità è evidenziata nel personaggio del tedesco proprietario del coccodrillo, che si preoccupa unicamente dell’animale perché è la sua fonte di guadagno, la meschinità si riflette nel protagonista Ivan, che accoglie la sua nuova condizione con entusiasmo, poiché vede nella situazione una possibilità di ottenere prestigio, riflettendo l’ironia di Dostoevskij sui presunti filosofi e teorici del progresso scientifico e del positivismo ottocentesco. A livello formale, Dostoevskij utilizza un linguaggio satirico e ironico per sottolineare l’assurdità della situazione fantastica, che è anche, secondo l’autore, l’assurdità del crescente interesse russo per gli investimenti stranieri e il capitalismo occidentale. Il narratore in prima persona, Semen Semenyc, adotta un tono distaccato, sottolineando con indifferenza eventi straordinari. Il contrasto tra il contenuto straordinario e lo stile narrativo genera un effetto comico all’interno della narrativa, mettendo in luce lo straordinario umorismo di Dostoevskij, preservato nella versione italiana dall’ottima traduzione di Serena Prina. L’autore delinea una magistrale combinazione tra critica sociale, umorismo ed elementi surreali nel racconto, il che rende Il coccodrillo un’opera unica nel corpus dostoevskiano, offrendo spunti di riflessione sulle contraddizioni sociali della Russia dell’epoca. Recensione di Giovanna de Campos Mauro Fëdor Dostoevskij, Il coccodrillo, traduzione dal russo di Serena Prina, 2024, Feltrinelli, pp. 97, ISBN: 9788807904783
Le truffe editoriali di Stelvio La Faina
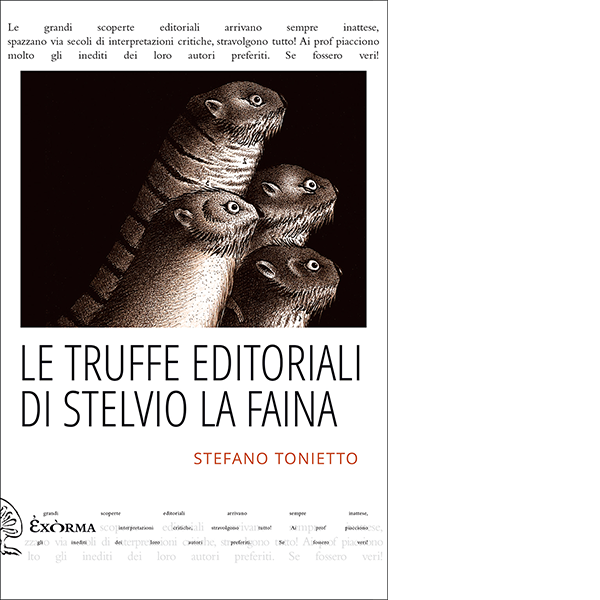
“I libri si parlano tra loro, Adso. E si rubano tra loro, anche. (Umberto Eco, forse)” Con questa citazione si apre Le truffe editoriali di Stelvio La Faina di Stefano Tonietto, un pastiche letterario divertente e raffinato. L’autore, padovano, è un insegnante di liceo e ha pubblicato diverse parodie letterarie sia in prosa sia in versi. Tra le sue ultime opere, figurano Altri dodici Cesari (2022), una riscrittura dell’Inferno dantesco in forma di lipogramma in A (Il divino intreccio, 2021) e un poema «comicavalleresco» in ottave (Olimpio da Vetrego, 2010). Le truffe editoriali di Stelvio La Faina immagina la pubblicazione, da parte di un «Editore» anonimo, della divertente antologia di brani rinvenuta nella casa editrice La Faina a seguito del suo fallimento. L’editore Stelvio La Faina è fuggito in Bolivia e il mondo delle lettere non parla che di questo «triste capitolo per l’editoria e la cultura italiana». L’Editore si dissocia dal linguaggio che Stelvio impiega nei propri scritti, «files narcisisti e ossessivi», che rivelano la «predisposizione truffaldina» del fuggiasco, ma si ritiene fortunato ad essere entrato in possesso del materiale, ossia palesi riscritture dei testi di grandi poeti e prosatori della letteratura. Stelvio, prima di venire inchiodato dalle indagini, aveva spacciato per inediti svariati scritti, tra cui le Omelette morali di Giacomo Leopardi, il Canzoniere per Laula di un certo Francesco Tetrarca e Il torvo di Edgar Allan Poe. Vestendo i panni del narcisista Stelvio, Tonietto dà prova delle proprie capacità di fine studioso e pungente parodista in componimenti come, appunto, quelli per Laula: «Parlo toscano ed ella non mi bada, | parlo latino e si riman di ghiaccia, | parlo lingua d’oil, mi ride in faccia, | parlo lingua d’oc, poco le aggrada; | scrivo sonetti, e va per la sua strada, | scrivo in prosa volgar, ma lei mi scaccia, | scrivo in esametri, e mica par le piaccia, | scrivo sermoni, e mi vòl dar di spada». Oltre ai materiali «inediti», l’Editore pubblica anche altri testi trovati nel computer di Stelvio, probabilmente destinati a diventare un’audace autobiografia. Il lettore si diletta così leggendo alcuni spaccati di vita quotidiana a La Faina Editions, in cui, alle accorate preoccupazioni della segretaria, seguono le risposte insolenti e ammiccanti di Stelvio, che provocano immancabilmente le esasperate reazioni di lei. Oltre agli endecasillabi tetrarcheschi, Tonietto emula le peculiarità stilistiche di celebri autori tra cui «un Eugenio Montale inedito e per certi versi imprevisto»: Stelvio racconta di come Montale, in un imprecisato manoscritto, abbia composto L’infinito immedesimandosi in Giacomo Leopardi, «un Leopardi però moderno, non più confortato dalle illusioni». L’ultima quartina recita così: «Vedi, torno sovente a questo parco, | a questi amari greti, a questi bossi, | e chissà che un bel dì vi trovi il varco | per l’infinito: ed a chi resta, gli Ossi». L’editore nota compiaciuto come le tre quartine presentino «frequenti ipermetrie» e un «lessico aspro e disarmonico», in perfetta linea con le scelte stilistiche di Montale. Le truffe editoriali di Stelvio La Faina offre una piacevole lettura di noti componimenti in chiave parodistica, regalando una colta panoramica su testi, per la maggior parte, sedimentati nella cultura dei lettori. Recensione di Noemi Quarenghi Stefano Tonietto, Le truffe editoriali di Stelvio La Faina, 2024, Exorma, pp. 208, ISBN: 9788831461603
La mia ingeborg
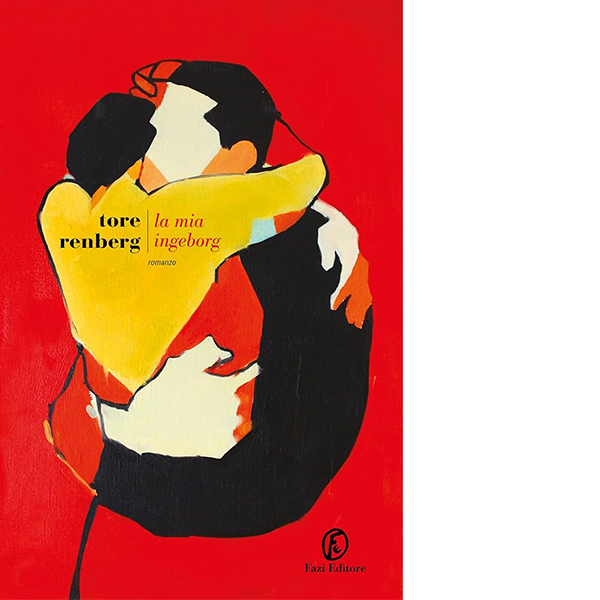
“C’era qualcosa che non andava con la bocca di Oddo. Oddo, diceva. Non era in grado di pronunciare il suo nome, Otto, come facevano gli altri, ma solo come gli sembrava di sentirlo dire con le sue orecchie. Devi cercare di dire la T, gli suggerivo. D, diceva. Riprova. T. E nessuno potrà più canzonarti. Canzonarmi?, chiedeva Oddo. Sì, devi imparare a difenderti da solo e, se vuoi imparare a farlo, devi saper pronunciare bene il tuo nome”. Tore Renberg è nato nel 1972 a Stavanger, in Norvegia. Il suo esordio letterario si colloca nel 1995 con la raccolta di prose brevi Sovende floke (non tradotto in italiano), alla quale seguono raccolte di racconti, quindici romanzi, il libro di saggi På fest hos Literaturen (2012), e una cospicua produzione di libri per bambini. Riconosciuto dalla critica come uno degli autori norvegesi più importanti degli ultimi anni, Renberg, è l’autore di Tollak til Ingeborg, romanzo pubblicato per la prima volta nel 2020 e, ad ora, il suo più grande successo letterario, candidato al Premio Strega Internazionale del 2024. Tollak della valle è un uomo taciturno, schivo, dal sangue amaro. Ormai vecchio e solo, la sua vita non è che il continuo riflesso di un passato perduto, nello specchio a cui tuttavia rifiuta tutti i giorni di specchiarsi. Non gli resta altro che il proprio nome, l’affermazione di sé, la dimostrazione di avere dentro qualcosa delle proprie origini. È proprio l’indifferenza verso questi ricordi ciò che rimprovera ai propri figli e al mondo che lo circonda, ed è questa distanza che lo fa sentire incompreso e abbandonato. Tollak vive nel passato che ha condiviso con l’amata moglie Ingeborg, scomparsa ormai da anni: solo il ricordo di lei l’ha tenuto in vita. Non ha più rapporti né con il figlio Jan Vidar, che accusa di essere un “senza palle”, né con i nipoti, a suo dire “mani morte, corpi morti e piedi morti”, incapaci di sopravvivere, a differenza sua, solo con il lavoro delle proprie mani. La figlia Hillevi lavora invece in università, è una femminista che riscrive “quell’epoca diversa” che Tollak idealizza, parlando con parole che non ha imparato a casa del padre. Unico suo confidente è Otto, o meglio Oddo, il figlio disabile, con cui abita l’isolata casa di famiglia. C’è però qualcosa, nella figura del vecchio Tollak, che finisce per rivelare le sue profonde contraddizioni; è un uomo di poche parole che tuttavia non può impedirsi di raccontarci la sua storia, un uomo che solo con sua moglie, dice, è stato in grado di esprimere i propri sentimenti. Eppure, costruisce una narrazione che, per quanto frammentaria, si rivela essere un vero e proprio monologo, un racconto senza interlocutore, in sostanza, un memoriale. Nessuna altra voce affiora dalla nebbia della mente di Tollak, non i figli, non la moglie. Ingeborg resta idealizzata, lontana, esterna alla storia, poiché solo la versione di Tollak giunge al lettore. Ingeborg è l’unico personaggio che non può pronunciare direttamente il suo nome. Un bicolore gioco di simmetrie generazionali si infrange, in primo luogo contro la simbologia animale che identifica i personaggi, e che è sottesa a tutta la narrazione; in secondo luogo, con la nascita di Oddo, unica evidente increspatura nell’autodifesa del padre. Tollak finisce per odiare la sua immagine riflessa, quegli occhi spiritati che non riconosce come suoi, ma che lo costringono, come il vecchio marinaio, a cercare una forma di assoluzione nel racconto. Al lettore resta solo la fuliggine, la percezione di una lacuna, di un oscuro non detto, nonostante il dichiarato obiettivo del protagonista sia un resoconto efficace; il residuo di una memoria già per sua natura destinata a rivelarsi incompleta e deformata. Qualcosa manca alla fine di Tollak til Ingeborg, e sta proprio qui la forza del romanzo; forse il vuoto che sancisce i limiti della ricerca del nostro passato, o forse, più semplicemente, la voce di Ingeborg stessa. Recensione di Leonardo Guizzetti Tore Renberg, La mia ingeborg, tradotto dal norvegese da Margherita Podestà Heir, 2024, Fazi Editore, pp. 180, ISBN: 9791259671257