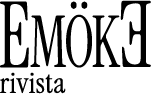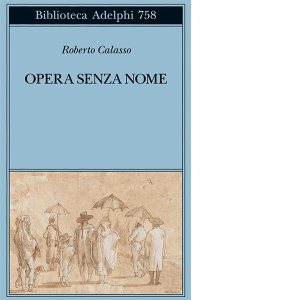
“L’ Opera è qualcosa dove ciò che separa le singole voci è molto più vasto delle voci stesse, simili a isole nella corrente di un mare illimitato. Ogni volta, in quelle isole, lo stile è diverso, come se ospitassero una vegetazione che solo in parte si ripete. Unica è solo la corrente che sostiene l’insieme. Le isole non si avvicinano mai quanto basta per unirsi, al massimo raggiungono una prossimità sufficiente per azzardare fragili ponti. O traghetti. Di regola, occorrono saldi battelli per passare da un’isola all’altra. Talvolta transatlantici.”
Opera senza nome è l’espressione con cui Roberto Calasso definisce l’insieme degli undici libri – da La rovina di Kasch (1983) a La Tavoletta dei Destini (2020) – che compongono la sua opera, per la quale rigetta la categoria di ‘enciclopedia’: «Non posso dire che l’unità dell’Opera sia sempre percepita», scrive, «eppure so che questi libri sono concatenati. Forse anche per capirlo meglio ho scritto queste pagine». Per decenni Calasso ha osservato i suoi libri sparpagliarsi nelle biblioteche, non solo in lingue diverse, ma anche tra le sezioni di narrativa e di saggistica, e nel tornare retrospettivamente al momento della creazione dei suoi testi ne rivendica l’originalità ricercata, il desiderio di inventare una forma nuova che «accogliesse occasionalmente frammenti di forme esistenti».
Questo libro rappresenta una sorta di testamento interpretativo, una biografia della sua opera, una libera riflessione sulle connessioni profonde che rilegano entro un unico progetto astratto le migliaia di pagine scritte dal fondatore di Adelphi, morto nel 2021. E, per quanto più breve, questo commento autoriale non è meno denso delle opere che ha per oggetto.
Mentre il resto del libro segue alcuni nuclei tematici che innervano la sua produzione, il primo capitolo è dedicato alla forma: Calasso si sofferma qui sui generi attribuiti ai suoi testi, sull’uso delle immagini e delle note nelle varie edizioni, sul rapporto tra invenzione e fonti. Nei capitoli successivi diventa evidente come la genesi dei libri presi in esame e la loro successione abbiano lo scopo di mostrare l’intenzione dell’autore in continua evoluzione, di rivelare i fondamenti ragionativi, filosofici e letterari di un’Opera talmente carica di riferimenti da produrre una costellazione di richiami senza un unico centro tematico o ideologico.
«Ero attratto dalla possibilità di accumulare racconti e materiali di ogni sorta e di celare il pensiero fra le righe della narrazione», scrive l’autore di Le nozze di Cadmo e Armonia (1988), «inclinazione per le storie che inglobano il pensiero, piuttosto che per l’inverso».
L’Opera senza nome, a sua volta, pur spaziando tra diversi campi del sapere – emblematici in questo senso Il rosa Tiepolo (2006) e La Folie Baudelaire (2008) –, non tratta i libri su cui si fonda come singole voci enciclopediche, ma li mescola ripetutamente: i personaggi che li abitano permettono un dialogo indiretto, in cui sono i libri stessi a comunicare tra loro, accostati dalla voce dell’autore che conosce i punti di contatto tra episodi lontani. Questo volume è un post scriptum che rivela un legame più profondo fra le opere di Calasso, ma funziona, al tempo stesso, come un’introduzione che poteva essere scritta solo a conti fatti.
Quello che resta da capire è come, nel concreto, l’autore sia in grado di compiere un’operazione così ambiziosa; l’unico modo possibile è riportarne un esempio:
Una estrema vicinanza o quasi sovrapposizione nel titolo si ha fra Ka (1996) e K. (2002). E al tempo stesso la massima distanza (Kafka ha avuto ben pochi contatti con l’India e i testi indiani). Di fatto, K. prova a mostrare esattamente perché e come il personaggio chiamato K. in Kafka è diverso da qualsiasi altro personaggio nella storia del romanzo, così come Prajāpati era diverso da ogni altro dio del pantheon vedico. Dopo tutto, i libri nascono anche così, da qualche riga in un libro precedente dell’autore, che può essere radicalmente differente, come lo è Ka da K. Già per questo: Ka tratta di una prodigiosa molteplicità di dèi e demoni mentre Kafka puntigliosamente evita il nome Dio e, se anche talvolta parla di “dèi”, questo accade assai di rado e con ogni cautela.
Recensione di Giacomo Bottura
Roberto Calasso, Opera senza nome, 2024, Adelphi, pp. 160, ISBN: 9788845938931