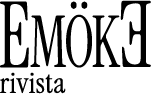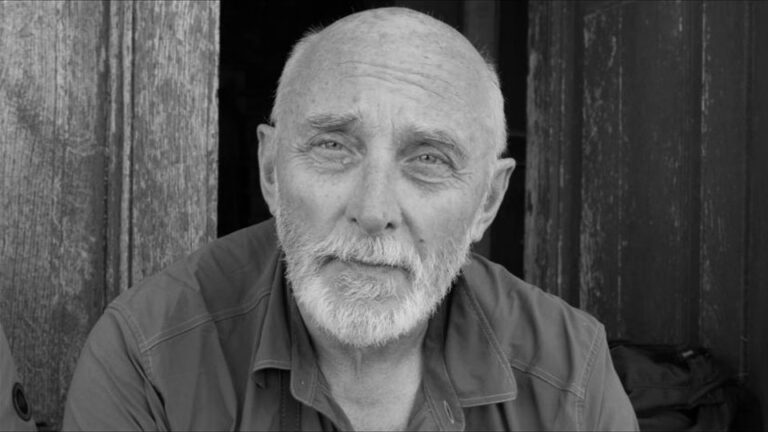
Intervista a Paolo Rumiz
Ha viaggiato tanto nella sua vita, in luoghi vicini e lontani. Se dovesse ripartire adesso, dove andrebbe, con quale mezzo e perché?
Vorrei andare a vedere i paesi distrutti dalla guerra, cioè Gaza e Israele – vorrei vederli entrambi, anche se il loro destino è diametralmente opposto – e vorrei anche vedere le due parti dell’Ucraina, quella in mano russa e quella in mano ai legittimi proprietari, per sapere davvero cosa pensa la gente di quanto è accaduto e capire quanto la politica, che ha voluto tutto questo, ha interpretato davvero la volontà delle persone. Gaza è un posto talmente piccolo che lo si può attraversare a piedi, ma l’Ucraina va percorsa con i mezzi pubblici, perché già durante il viaggio bisogna mescolarsi alla gente, e approfittare dell’occasione meravigliosa che il treno fornisce di incontrare persone durante il trasferimento. Io ho ricordi meravigliosi, anzi indimenticabili: mi torna in mente, per esempio, un reduce russo dell’Afghanistan incontrato su un treno che da Murmansk portava verso San Pietroburgo. I treni russi sono estremamente interessanti, così come quelli che passano per l’Ucraina: nel mondo slavo, infatti, l’umanità è molto più leggibile che nell’Europa occidentale.
Qual è il suo rapporto con la lettura? Quali sono stati gli autori e i libri più importanti per la sua formazione?
Sia dal punto di vista giornalistico che per quanto riguarda la scrittura, per me è stato molto importante Dino Buzzati, che è stato contemporaneamente giornalista e scrittore, e che quindi aveva questo doppio aspetto che contraddistingue anche me. Siccome sono un giornalista che ama viaggiare, e quindi raccontare le cose viste durante questi viaggi, l’autore che in assoluto – ma in assoluto senza la minima esitazione – prediligo, che mi ha insegnato tantissimo, è Nicolas Bouvier. Mi riferisco in particolare al suo libro La polvere del mondo (L’usage du monde, 1963), perché ha la capacità di descrivere minuziosamente ciò che incontra e, nello stesso tempo, di raccontare il contesto in cui tutto questo avviene (contiene delle immagini straordinarie sia di paesaggi sia di persone) e, contemporaneamente, ha anche l’abilità di cogliere l’occasione di questo viaggio per riflettere su se stesso. Se vogliamo andare alle origini, un libro che mi ha segnato è stato, all’età di nove anni, il diario di bordo di Cristoforo Colombo. E poi, l’anno dopo, a dieci anni, sempre grazie allo stesso maestro elementare, il diario di bordo di Antonio Pigafetta, che era colui che ha steso questo fedele racconto di viaggio per conto di Magellano, l’uomo che per primo ha fatto il giro del mondo. Ovviamente, per me è stato importante anche Moby Dick. Recentemente, tra le opere che mi hanno molto impressionato ci sono soprattutto libri di poesia: uno, in particolare, è Omeros (1990) di Derek Walcott, autore premio Nobel per la letteratura. Lui è un meticcio, metà olandese e metà africano – anche se gli africani di quelle isole, le Antille, sono importati, non sono nati lì, e quindi potrei dire che “è un negro con gli occhi chiari” –. Walcott ha scritto dei libri anche versificando, creando versi sciolti molto belli. Ha composto un’epopea – l’epica è un genere a cui sono molto legato – e quel libro mi ha profondamente segnato. Lo stesso vale, in ambito giornalistico, per la lettura di Ryszard Kapuściński. Il libro che prediligo tra i suoi è, senza dubbio, Imperium (1993), che racconta il viaggio all’interno dell’Unione Sovietica in disfacimento, osservando davvero che cosa accade: all’interno di questo resoconto ci sono veramente dei pezzi di altissima letteratura.
Qual è il suo rapporto con la scrittura? Quando ha iniziato a scrivere e perché?
Ero già abbastanza bravo a scrivere alle elementari e alle medie, anche se in terza elementare mi ero scontrato con un’insegnante che disse che scrivevo con le scarpe. All’epoca – questo lo dico molto bene ne La cotogna di Istanbul (2010) – io non ho protestato, ma, tra me e me, ho detto: “Adesso ti farò vedere come si può e, anzi, come si deve scrivere con i piedi, perché soltanto chi attraversa il mondo può avere veramente delle storie da raccontare”.
Ne sono tuttora convinto, anche se ormai, alla mia età, sto cominciando a scrivere storie di fiction; ad ogni modo, anche in quelle storie di fiction, io attingo a pezzi di realtà, che poi mi diverto a montare in modo diverso. Si può dire, quindi, che mi sono messo a scrivere per il desiderio di contraddire quest’idea e di dimostrare che per raccontare è necessario muoversi, attraversare il mondo. C’è chi è capace di scrivere anche senza farlo, ma io, che sono forse più vulnerabile, più debole, ho sempre – davvero sempre – bisogno di rifarmi alla realtà: anche quando scrivo poesie sul mio stato d’animo, mi rifaccio a qualcosa che ho visto o sentito, che si è depositato nella mia anima e che riemerge a distanza di tempo, nei momenti più imprevisti. Riguardo a questo, una cosa che ci tengo a dire, non in quanto giornalista ma in quanto scrittore, è che i momenti di massima comprensione dei fatti – ma anche di se stessi – avvengono nel cuore della notte, nelle ore del buio più profondo, tra le tre e le cinque del mattino, quando il nostro inconscio è più sincero e riesce a percepire cose che nel frastuono della vita quotidiana non sono percepibili. Viviamo immersi in troppo rumore, in troppa luce per poter attraversare le penombre di noi stessi, i silenzi necessari.
Nei suoi libri è facile riconoscere un legame con il suo lavoro per i giornali. Che differenze trova – se ce ne sono – tra queste due pratiche di scrittura?
Sono riuscito a illustrare efficacemente questo concetto ad una classe elementare in Germania, dove ho spiegato che, mentre il giornalista deve dimenticare chi è e raccontare soltanto ciò che vede senza altri commenti, lo scrittore, invece, deve mettere se stesso dentro la scrittura, e per questo racconta comunque cose vere o verosimili, ma mettendo dentro anche il proprio sentimento. Il poeta, invece, va ancora oltre perché, in quanto scrittore di versi, entra nel mondo complicato delle metafore e dei simboli. A questi bambini sono riuscito a spiegare anche un altro concetto. Ho disegnato sulla lavagna, da una parte, delle nuvole che lasciavano cadere la pioggia, e, dall’altra, gli occhi di una persona che lasciavano cadere delle lacrime. Poi ho chiesto alla classe: “Cosa succede se sposto le lacrime sotto le nuvole e la pioggia sotto gli occhi?”, e loro hanno cominciato a discutere. I bambini hanno capito perfettamente che questo incrocio, questo attribuire qualcosa di umano alle nuvole e qualcosa di naturale e di universale agli occhi dell’uomo, è una metafora per dire che i nostri sentimenti, in realtà, non restano chiusi nell’anima, ma possono essere letti in modo molto più largo, più alto.
In un’intervista ha affermato di essere «francese per cultura di viaggio». Che cosa intendeva? Chi sono i suoi maestri nell’arte del viaggio lento?
Per quanto fossi estremamente curioso di sapere cosa stava ad Oriente, dove c’era il mondo comunista, i miei primi viaggi li ho fatti verso Occidente, in direzione della Francia – poiché conoscevo bene il francese. A Parigi ho fatto un’esperienza che mi ha segnato per sempre: dato che sono allergico alle strade dritte – che ritengo una violenza sulla natura e sul naturale labirinto urbano – e siccome sapevo che la città era stata completamente modificata dalla costruzione dei grandi boulevards, quasi tutti rettilinei, che attraversano brutalmente la città dopo aver fatto a pezzi un sacco di casette proletarie, consapevole di tutto ciò mi sono divertito, prima di partire, a costruire una mappa personalizzata della città, senza i boulevards. In qualche modo, quindi, ho ricostruito la città medievale, mettendo insieme i pezzi che erano stati separati da quei grandi canali impressionanti quali potevano essere il Boulevard Raspail o il Boulevard du Montparnasse. Quando sono arrivato a Parigi – avevo sedici anni, o forse diciassette – ho camminato, in tre settimane, per quasi quattrocento chilometri, facendo tutte queste strade minori, evitando i boulevards in cui è facile orientarsi, incontrando tantissima gente. Ho attraversato la città, come immergendomi in essa, percorrendo queste viuzze a zig-zag: è stata veramente una grande avventura. Questo mi ha insegnato che, per capire le città, bisogna allontanarsi dalle grandi strade, nascondersi come un partigiano, darsi alla macchia; questa cosa mi ha poi aiutato ad essere sensibile, anche come giornalista, alla voce dei luoghi dimenticati, minori rispetto a quelli troppo illuminati dagli spot pubblicitari della televisione.
Come pensa possa contribuire uno scrittore a diffondere un’idea di Europa in cui gli europei possano riconoscersi?
Noi viviamo uno scontro di narrazioni – non c’è solo lo scontro delle armi e dell’economia, ma c’è anche lo scontro tra narrazioni, tra narrative. Facciamo un esempio: appena salito al potere – anche se già prima c’erano state forti avvisaglie che sarebbe andata così –, Donald Trump ha fatto una serie di affermazioni che sembravano rappresentare esattamente la pancia profonda dell’America; ma, soprattutto, ha portato avanti un’offensiva narrativa, facendo ogni giorno decine di annunci mirati a confondere l’avversario, il quale non era capace di rispondere. Ancora oggi, a distanza di parecchie settimane dal suo insediamento a Washington, il partito sconfitto – quello dei Democratici – si muove come un pugile disorientato, che non è in grado di reagire ai colpi subiti. Questo non solo perché l’attuale opposizione ha dormito sugli allori, ma anche perché non ha, al suo interno, degli intellettuali o degli scrittori capaci di proporre una contronarrazione. Ecco, io, in questa situazione, trovo che siano importanti, più dei politici, degli scrittori capaci di fornire alle democrazie, oggi grandemente in pericolo, un arsenale di parole utili a contrastare questa invasione nel mondo politico della prepotenza e del razzismo. Io sono dell’idea – e mi meraviglio che non sia stata ancora formulata – che a questa moltiplicazione degli annunci, utile per frastornare l’avversario, si debba rispondere amplificando, non contrastando, quegli annunci che sono in gran parte dei bluff: aggiungere ai bluff di Trump dei bluff ancora più grandi. Ad esempio: se lui vuole comprare la Groenlandia e fare del Canada il cinquantunesimo stato americano, bisogna fare come la Danimarca, che ha rilanciato: “Allora noi ci compriamo la California, perché abbiamo bisogno di sole e di un mare grande come il Pacifico, con le foreste e con le nevi, che da noi non le abbiamo”. Lo hanno detto raccogliendo decine di migliaia di firme, ma in un modo che non voleva essere una cosa seria – era chiaramente una presa per il culo. È necessario, quindi, scimmiottare per creare nel pubblico un riflesso ironico rispetto ad una cosa che, altrimenti, verrebbe presa sul serio.
Questo è il lavoro degli scrittori, ma gli scrittori tacciono: viviamo in un momento in cui gli intellettuali sembrano stare in silenzio. Io mi meraviglio, perché nell’epoca in cui viviamo non è più possibile guardarsi l’ombelico e sono, perciò, fermamente convinto che oggi il compito degli scrittori sia quello di ridisegnare la democrazia, una realtà che questi progressisti hanno trasformato, con un’eccessiva preoccupazione del politicamente corretto, in quello che io chiamo il «regno dello sbadiglio». Il politicamente corretto non deve arrivare al punto di non mettere nelle condizioni di rispondere a un insulto; dev’esserci correttezza, ma non timidezza nei confronti del violento, perché è questo ciò a cui stiamo assistendo al momento.
Come potrebbero gli insegnanti sconfiggere il razzismo e promuovere l’idea di una convivenza pacifica fra differenti culture nei loro alunni? E come potrebbero creare il desiderio di un’Europa unita?
Bisogna, innanzitutto, spiegare due cose, perché viviamo schiacciati tra due ipocrisie. La prima è un’ipocrisia di destra, che finge di non sapere che, in assenza di migrazione, l’Europa scomparirebbe sul piano tanto dell’economia quanto della cultura; l’altra è l’ipocrisia dei progressisti, i quali fingono di non sapere che qualsiasi immigrazione produce, in chi abita in un determinato territorio, uno spaesamento, un’iniziale paura, un rifiuto e un’inquietudine, soprattutto se questa immigrazione non è controllata. Senza dubbio serve ricordare questo, ma serve anche – e questo è indispensabile – raccontare le storie della nostra emigrazione. L’Italia, da sola, ha conosciuto un numero di emigranti infinitamente superiore al numero di immigrati che sono arrivati da noi negli ultimi quindici anni: noi siamo emigrati a milioni.
Al tempo stesso, dobbiamo tenere presente che anche il cibo consumato in Europa viene da lontano – come le patate dall’America e le melanzane dal Sud-Est asiatico. La capacità dell’Europa, infatti, è stata proprio quella di elaborare prodotti provenienti da lontano e farne qualcosa di proprio: per riprendere l’esempio delle melanzane, nella parmigiana c’è un’identità italiana profonda, anche se è fatta con ingredienti che vengono da lontano. Nella stessa ottica è importante raccontare – e questo noi non lo sappiamo – che buona parte della grande musica popolare europea viene da popoli migranti: mi riferisco a generi quali il blues, il klezmer o il flamenco. Quest’ultimo, per esempio, è stato fatto dalle popolazioni rom che venivano dall’India, le quali, a loro volta, avevano assorbito e trasformato la musicalità proveniente da quell’enorme paese che si estendeva tra la Grecia e la Persia; questa musicalità, che è arrivata fino in Andalusia, si è poi trasferita di nuovo in Occidente – nell’Europa centrale e, soprattutto, nei Balcani – attraverso la diaspora degli Ebrei cacciati dalla Spagna nel 1492. Dopotutto, la grande musica è sempre frutto di sradicamenti: basti pensare a ciò che hanno prodotto, sempre in ambito musicale, le comunità africane dopo essere state deportate in America in condizione di schiavitù.
Un altro aspetto che va spiegato, dati alla mano, sono le implicazioni del nazionalismo: se, infatti, alzassimo di nuovo dei confini tra Italia e Austria o tra Germania e Francia, saremmo tutti immancabilmente più deboli. A quel punto, sul piano politico non conteremmo più nulla e il primo Elon Musk di passaggio potrebbe fare di noi ciò che vuole. Il nazionalismo, in sostanza, equivale a un’«irrilevanza», ovvero a una mancanza di importanza rispetto ai grandi poteri mondiali, e corrisponde a un’impossibilità di difendersi. Per tornare allo scenario di prima: così come Trump pretende di comprare la Groenlandia, qualcuno dalla Cina potrebbe venire a reclamare l’Italia, offrendosi di comprarla, riempiendoci di soldi, e senza neanche doverci far guerra; a quel punto sì che saremmo tutti schiavi.
Sta già scrivendo un altro libro?
Ho finito di scrivere un’opera garibaldina, che uscirà il 27 maggio. Il libro racconta come Garibaldi, ai miei occhi – ma anche ai suoi –, sia stato, in fondo, il grande sconfitto del Risorgimento, perché l’Italia che nacque da quell’esperienza non era quella che lui sognava. Immagino come Garibaldi, se tornasse oggi in Italia, giudicherebbe i politici attuali.
15 febbraio 2025
Intervista a cura di Sofia Borghesan